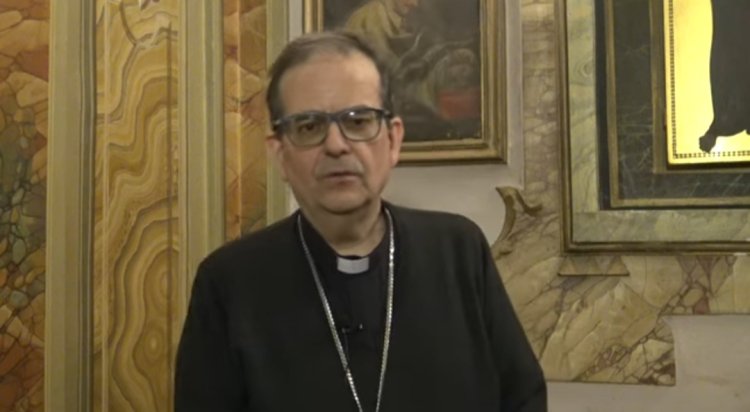Una conversazione sul rapporto uomo-natura e sulla scrittura con un vivaista-poeta

Ho conosciuto Giuseppe Salvatore esattamente un anno fa ad una festa in campagna che, in tempi decisamente più sereni di quelli correnti, voleva celebrare l’affacciarsi della primavera mediante l’arte, la musica e la poesia. Scrivo “conosciuto” perché in quella circostanza ho avuto modo di scoprire qualcosa in più su di lui, come il suo amore per la poesia, di cui prima non ero a conoscenza, nonostante l’avessi già incontrato diverse volte al suo vivaio alle Volte Alte. Già da quelle brevi conversazioni però avevo intuito qualcosa; Giuseppe quando parla delle sue piante, di cui segue e cura meticolosamente ogni stadio della vita vegetativa, incanta, come ogni appassionato che si ritrova a ragionare ad alta voce di quella cosa che genera in lui il “sacro fuoco”. Botanica e poesia d’un tratto si mescolano e non hanno più un confine. Ciò mi ha suscitato interesse e ho voluto discutere insieme a Giuseppe della missione del vivaista, dell’Antropocene, del concetto di passione e di poesia. Abbiamo iniziato il discorso cercando a ritroso nel rapporto con la sua città natale, Milano, le fondamenta del suo amore per la natura, che lui crede essere semplicemente un istinto innato: «Il caos della città, delle fabbriche, dei gasometri, mi è sempre stato stretto». Ma affacciandosi alla finestra poteva ammirare in lontananza le montagne di tremila metri, un attimo di respiro dalla frenesia cittadina che cominciò a visitare assiduamente: «Era un ambiente che mi faceva stare bene; da lì guardavo la città e quando tornavo mi rabbuiavo». Giuseppe ha frequentato il Liceo Classico; oltre la natura, lo studio ha rappresentato per lui un’oasi di piacere in cui rinchiudersi:«La poesia mi è sempre piaciuta, il pensare, il capire l’essere umano nel suo pensare, nel suo esprimersi, è sempre stato per me una grande passione. Però ero legato anche a questo ambiente naturale». Capisco perfettamente la solo apparente contraddizione di dividersi tra due mondi diversi, ma la scrittura e la natura hanno difatti una cosa in comune; vogliono l’uomo solo, poiché per ottenere una contemplazione autentica esigono entrambe profonda concentrazione e riflessione. Un’esigenza così vitale plasma inevitabilmente le scelte che si compiono, per cui inizia ad «ambire sempre di più a vivere in quel posto (quello naturale), più che in uno cittadino» anche se quest’ultimo metteva in tavola molte più possibilità: il lavoro, gli amici, i divertimenti, la cultura, tutto ciò che la mente umana è riuscita a partorire nei secoli. «Però c’era anche questa parte che aveva milioni di anni e che mi reclamava in un certo modo». Da lì la decisione di trasferirsi nel 1982 a Siena, in una delle campagne più lussureggianti al mondo, e di iniziare qui questa avventura gestendo un’azienda agricola «con risultati catastrofici. Immagina uno che viene da Milano e che si mette a seminare l’orzo, l’avena per i cavalli…; non sa nemmeno da che parte rifarsi! Però eravamo (lui e gli amici con cui ha deciso di gettarsi in questa impresa) molto volenterosi e abbiamo imparato abbastanza. C’è stata anche gente di qua che ci ha aiutato con tenerezza e noi rubavamo tutto con gli occhi, perché rappresentava una scoperta. Le prime esperienze pratiche di vita a contatto con la terra per me sono state memorabili; non erano vite cittadine, a me non era mai successo di pestare per ore la terra. Prima pestavo l’asfalto, il marciapiede, le mattonelle, gli ascensori; pestare la terra è una sensazione che per uno che abita qui è quasi banale, per me è stata una rivoluzione». Poi arriva il progetto del vivaio: «Io e un mio carissimo amico di Padova, Andrea, ci siamo incrociati e abbiamo deciso di provare. È da più di trent’anni che viviamo del nostro lavoro insieme». Una decisione che ha portato Giuseppe a condurre una vita completamente nuova ovvero quella di «un cittadino che rinuncia per un bisogno superiore al benessere e all’agio che offre la città, anche con fatica». Per quanto possa sembrare idilliaco lavorare con le piante, mi racconta che ci sono mattine in cui la temperatura è di meno otto gradi, in cui diluvia e «non sai cosa fare». Effettivamente devi essere molto in gamba per vivere di un mestiere che è sempre in balia di forze maggiori e incontrollabili come il clima:«Riesco a vivere con un lavoro che non è un’attività commerciale vera e propria, ma un’attività naturale. Io vendo una cosa naturale; propongo, costruisco e creo studiando la natura e usando i suoi meccanismi». Mi spiega la differenza tra il canale della produzione e quello della commercializzazione; il primo consiste nel seguire personalmente la crescita delle piante che verranno vendute, perciò nel suo vivaio si trovano principalmente specie che si adattano bene al clima del nostro territorio. Gli chiedo se usa principalmente tecniche naturali: «Sì, facciamo dei trattamenti biologici nel limite del possibile, perché comunque questo è un campo in cui vi è ancora molto da ricercare».

Finiamo inevitabilmente a parlare del confine tra uomo e natura: «Noi abbiamo una mente troppo matematica e geometrica; abbiamo bisogno di perimetri, aree, linee, sequenze, cose che in natura non esistono. Nel bosco non troverai mai le linee tra le piante; trovi tre piante qui, due qui…C’è una dinamica che è completamente diversa da quella che noi proponiamo nella nostra vita quotidiana; tu la macchina la metti lì, abiti al terzo piano…La nostra mente ha bisogno di questo. La natura funziona invece nell’accordarsi tra esseri viventi, per cui ci sono i parassiti, gli esseri che vivono insieme, quelli che sono vantaggiosi l’uno per l’altro, quelli che non vogliono nessuno intorno…C’è un equilibrio e un rispetto tra le varietà naturali che è superiore, perché le piante sono qua da molto più di noi e ciò significa che sono una varietà vivente vincente. Una pianta vive tremila anni, noi no. Una pianta riesce a costruirsi il cibo da sola, resta secoli nello stesso posto, per cui deve saper lottare, non può fuggire. Noi se vediamo un pericolo scappiamo, se abbiamo fame ci spostiamo, loro si nutrono e riproducono in un punto. Hanno inventato dei sistemi incredibili per sopravvivere di cui non ci rendiamo nemmeno conto. Noi siamo a spese di essi; respiriamo perché la pianta produce l’ossigeno come prodotto di scarto della fotosintesi. Il 90% della massa viva sulla terra è solo vegetale, calcolando anche le alghe ecc.… Noi siamo una meteora». E in riferimento alla nostra epoca, l’Antropocene, quella caratterizzata dal problematico rapporto con le risorse:«Non stiamo distruggendo il mondo, stiamo distruggendo noi. Ogni giorno nascono specie nuove, ne muoiono altre, il mare si alza e si abbassa… Gea, la Terra, ha degli equilibri incredibili. A noi che siamo specisti, che dunque ci sentiamo al centro di tutto, questo ci sconvolge, ma il mondo si adatta; la globalità ha le sue dinamiche, che sono provate e in costante mutamento e in questa continua evoluzione noi rischiamo di non essere considerati». Domando dunque se, venendo a mancare una specie importante come le api, si interrompe la catena:«Le api si ammalano perché entrano in contatto con un ambiente contaminato con trattamenti chimici e diserbi. Se spariscono le api, le piante si selezioneranno, moriranno, non si riprodurranno quelle che abbiamo costruito noi, ma altre, che hanno bisogno del vento o di un altro tipo di insetto, vivranno ugualmente. La catena che si interrompe non esiste, prende un’altra direzione. Il problema grosso è la convinzione dell’essere umano di essere il gestore di tutto, il centro intorno al quale gravita tutto». Ma in realtà non è così e la coscienza di ciò, dice Giuseppe, deve insegnarci il rispetto: «Devi studiare come non sfruttare; questo significa garantire la sopravvivenza della propria specie». L’uomo, come le altre specie animali, deve imparare la collaborazione: «Se tu gestisci bene la parte che ti dà mangiare, riscaldamento e medicine (perché tutto deriva da lì), vivrai come specie». Sembra un’impresa enorme smussare la gigantesca macchina che sorregge la nostra società e il nostro benessere, ma il tempo e la rapida scomparsa della fonte che alimenta l’abbondanza ci costringerà ad un necessario cambio di direzione. Qual è dunque la soluzione per non autodistruggerci? È possibile vivere un’esistenza totalmente naturale o non possiamo fare a meno di quella artificiale? «C’è il compromesso, che non è una cosa negativa, ma il saper scegliere tra cosa utilizzare ancora e cosa meno con coscienza. Ormai senza il telefonino non posso vivere, però posso imparare ad usarlo. Non posso vivere senza la macchina perché questa società ha costruito una scenografia tale che non posso non utilizzarla, però posso imparare ad usarla meno, prendere i mezzi, organizzarmi. Ciò rappresenta uno sforzo, una fatica perché il mondo va verso un discorso di velocità, per cui rallentare vuol dire mettersi da parte e a volte è difficile. Ma rallentando in realtà recuperi, inizi ad ascoltare cose che prima non riuscivi a sentire. Vale la pena o non vale la pena? Per qualcuno non vale la pena; bisogna buttarsi nella corrente ed andare con gli altri. C’è invece qualcuno che resta sul margine, rallentando vicino alla riva […] Non si può fermare la corrente; la nostra condizione umana ci porta comunque ad avere questo istinto di sopravvivenza, che però è deviato in un ambiente che non è di sopravvivenza, ma di affanno, di costante macerazione, di costante ricerca di beni che non sono realmente utili, ma sono indotti da una necessità del tempo. Ora se non c’è il telefonino dove vai? Vieni emarginato. […] Non puoi vivere totalmente naturale, puoi fare delle scelte, sapendo che sono dei compromessi necessari. Il compromesso è una cosa buona, non cattiva; se tu capisci che riesci a fare a meno di una cosa per un guadagno superiore non è un vendersi, ma un cercare qualcosa di meglio lasciando indietro qualcos’altro». In riferimento a questo discorso mi viene in mente un bellissimo film del 2007 diretto da Sean Penn, Into the wild; è ispirato alla storia vera di Christopher McCandless e affronta la spinosa questione della possibilità di una vita totalmente naturale.

Torniamo a concentrarci sul mestiere del vivaista e chiedo a Giuseppe qualche consiglio per aver cura del proprio giardino. Mi spiega che si tratta di un luogo comunque artificiale, che deve essere mantenuto per impedire il suo tentativo continuo di ritorno alla naturalità: «Costruire un giardino è una cosa difficilissima, perché le piante non sono tutte uguali; c’è quella che mangia di più, quella che ha bisogno di più sole, quella che vuole star da sola… È una conoscenza continua e costante e le variabili sono mille e ogni volta cambiano ogni anno. Per cui è necessario conoscere l’intimità della pianta, come funziona, così da poterla stimolare a tuo pro e a suo pro; questo è la base di qualsiasi progettazione in giardino. Una persona che progetta un giardino deve essere un botanico, un architetto, deve avere una certa sensibilità e mettersi a disposizione della committenza. Purtroppo c’è tanta ignoranza e in questa ignoranza ci vive una marea di gente che non sa fare niente. Devi guidare la pianta a fare qualcosa, non la puoi costringere. Ad esempio, quelle da frutto; io ti do la pianta, ma sei tu che la devi portare, convincere, a fare il frutto, che rappresenta la sua massima aspirazione, poiché lì c’è il seme per la riproduzione. La pianta non può compiere tutto il suo ciclo vitale, se tu cominci a potarla perché ti dà fastidio, non capendo che sta facendo i fiori». Il concetto di collaborazione è essenziale non solo nel nostro giardino, ma generalmente anche nel nostro rapporto con l’ambiente naturale: «Lo sviluppo agronomico dal dopoguerra in poi ha vissuto della chimica; ad essa è dovuto l’esplosione e anche il benessere che abbiamo avuto a livello alimentare. Cosa succede però; la natura non sopporta questa velocizzazione. L’abbiamo costretta a fare quello che vogliamo noi, non abbiamo collaborato. Per cui a questo punto la terra è in affanno, non produce più o meno, si ammala più facilmente e non è più in equilibrio. […] In Italia siamo sessanta milioni di persone che mangiano tre o quattro volte al giorno, tutti i giorni. Per trovare il cibo per sessanta milioni, tutti i giorni, sono necessarie una produzione e un’organizzazione incredibili. Se noi producessimo come cinquant’anni fa sarebbe impossibile avere questi ritmi». Immagino che lavorando a stretto contatto con l’ambiente naturale abbia visto da vicino gli effetti del cambiamento climatico: «Da trent’anni a questa parte le cose sono cambiate tantissimo. Ti dico banalmente l’anno scorso a gennaio la temperatura era meno dieci. Il 2020 è molto più caldo. Il fatto è che le piante si adattano al momento, non dicono: “ma l’anno scorso erano meno dieci gradi ed ero bloccata”. Cominciano perciò a pompare acqua, a gonfiare le gemme poiché è la temperatura adatta. Il problema è che arrivano le gelate e le gemme bruciano, ma la pianta si difende, sopravviverà e rifarà le gemme, non farà più quelle per noi, ma per sé non ha problemi. Il rapporto è sempre quello: quello di richiedere ad un altro essere vivente quello che ci interessa». Mi racconta delle richieste di alcuni clienti di piante, che magari hanno visto su Internet o in vacanza e che vorrebbero avere, ma che sono inadatte al nostro territorio perché abituate ad un clima totalmente diverso: «Se qui ci sono le gelate è inutile mettere i frutti. A Siena non si coltiva la frutta, è inutile piantare qui i meli perché c’è meno dieci d’inverno e più quaranta d’estate, quelli sono alberi che amano il freddo. Questa è una zona da viti e da ulivi. In Val d’Orcia ci sono il grano e i cereali, non puoi mettere i frutti, c’è un tipo di terreno che diventa mattone. Per questo il senese ha vissuto molto di allevamento, della raccolta delle castagne, della legna, di altre attività che hanno sostituito la coltivazione…Le piante che ci sono qua sono dei riferimenti importantissimi; in base a quello che nasce bene, capisci cosa puoi mettere. Il cactus dell’Arizona non potrebbe vivere qua. Queste piccole chiavi di lettura mancano. Per quanto acculturata sia una persona, queste banalità non si riescono generalmente a capire perché la distanza che abbiamo preso dall’ambiente naturale è troppa. Per cui tornare a comprendere quella lingua è difficile, c’è bisogno della scuola».

Il consiglio di Giuseppe dunque per sviluppare il cosiddetto “pollice verde” è quello di porsi umilmente in una predisposizione di conoscenza, non partendo con la voglia di raggiungere dei risultati, ma cercando di capire come arrivarci, con il rispetto dell’elemento da cui vuoi ottenerli: «Io non posso ad un bambino di tre anni insegnare i logaritmi o le funzioni, devo portarcelo passando prima dall’ABC, iniziando con le operazioni e lentamente guidarlo, non solo per se stesso ma anche per il decoro del mio lavoro come professore, a crescere come essere umano». Mi ricordo una volta di aver visto un programma sull’intelligenza delle piante e su come possano essere dei veri e propri esseri senzienti e ne accenno a Giuseppe: «A riguardo ci sono delle bellissime lezioni dello scienziato Stefano Mancuso su YouTube. Ha anche fondato a Firenze un laboratorio di Neurobiologia vegetale, pensa, neurobiologia; le piante hanno un linguaggio, si lanciano dei messaggi quando ci sono degli attacchi di parassiti, iniziano a produrre sostanze per difendersi, percepiscono dove si trova l’acqua e si dirigono verso di essa, è una cosa meravigliosa. Sono studi abbastanza recenti, di una ventina d’anni, giapponesi e italiani. Stefano Mancuso è un buon relatore di queste cose, è interessante perché ti rendi conto come non è un discorso di esseri diversi, ma di linguaggio diverso, che possiedono da millenni. Capirlo è necessario per trovare un vantaggio reciproco; se non c’è un vantaggio reciproco c’è la sopraffazione, in cui una delle due specie sparisce perché sopraffatta». Osserviamo come l’essere umano possieda delle caratteristiche uniche che in natura non si trovano:«L’umanità, il senso emotivo, del caritatevole non esistono in natura, dove è presente al contrario una selezione micidiale». Mi parla di un libro sulle cicogne che sta leggendo; questo animale solitamente genera cinque o sei cuccioli ogni volta e tende a buttare fuori dal nido gli esemplari più deboli, facendo una selezione, perché con le sue energie può nutrire solo quelli che instintivamente percepisce essere i più forti. Al contrario l’uomo con la sua inclinazione a voler aiutare coloro che sono più in difficoltà, immesso in questa spietata logica della sopravvivenza e della selezione naturale, sembra provenire da un altro pianeta: «La natura è crudelissima, ma il termine "crudele" lo abbiamo inventato noi».
Quell’umanità che non è presente in natura, Giuseppe la trova nell’altra sua passione, la poesia che rappresenta per lui «un piacevole momento di gioco, di svago, di scavo». Definisce anche questa parte di quell’istinto profondo che ha sempre avuto, una predisposizione come la musica per il musicista, l’arte per il pittore, lo sport per l’atleta…«Ho sempre visto il linguaggio come il mezzo per entrare in comunione con gli altri, ma anche con me stesso. La parola è come una pianta; tutti le peschiamo da uno stesso posto, da un bosco di parole; ci sono alcune che significano di più e la natura le favorisce e ripropone continuamente perché potrebbero essere vincenti. La tribù umana usa sempre gli stessi termini; una persona sensibile, che chiamo poeta, invece mette le parole insieme in maniera emotiva, riesce a dare un valore più alto anche a quelle più comuni, come “caffè”, su cui potrebbe costruire qualcosa di fiabesco». Gli chiedo se un giorno pubblicherà i suoi lavori:«Non ho questa ambizione di riconoscimento. A me piace molto nel guazzabuglio delle parole trovare quelle da mettere insieme per organizzare un pensiero. Ungaretti e gli ermetici per me sono il massimo; partono da un concetto che li ha tenuti svegli giorni e notti e riescono in tre righe a esprimere un pensiero eterno. Mi sconvolgono. A volte anch’io scrivo delle robe barocche, assurde e a quel punto entra in gioco il bisogno di essere compresi, non a livello uditivo o discorsivo, intendo la necessità di entrare nel profondo, di arrivare in un posto in cui la persona viene smossa. Dico sempre che il poeta è come un cecchino, colpisce inatteso nel posto giusto. Tu provi come un sussulto e lui sparisce nella tua gratitudine, ti ha dato così tanto pur colpendoti che rinasci in una maniera diversa. Se tu rileggendo qualcosa hai la stessa emozione funziona, sennò la butti». Cerchiamo una definizione di poesia e la differenza con il genere prosastico; Giuseppe pensa che la prima lasci più spazio all’immaginazione, la definisce un cucchiaio di legno con cui un bambino può inventare mille giochi, come fingere di essere uno spadaccino o una scavatrice…Il racconto invece richiede al lettore un adeguarsi ad un mondo già ampiamente costruito e definito:«La poesia pretende che tu riesca a dare al lettore la possibilità di entrarci dentro e di farla sua». Questa ricerca del termine esatto per esprimere un’emozione rappresenta la passione di Giuseppe:«Riuscire ad ottenere la sintesi della semplicità; è lì che risiede la genialità». E fa l’esempio di un noto scienziato: «Einstein è un poeta per costruire quella formuletta E=mc2, con tre elementi ha spiegato l’universo». Per concludere gli chiedo una poesia per l’articolo e mi lascia questa, dal titolo Resistenza:
Lancerò semi
scelti con cura
affinché portino frutto.
Non m’importa
a chi gioverà.
Forse sarò già lontano
Francesca Raffagnino